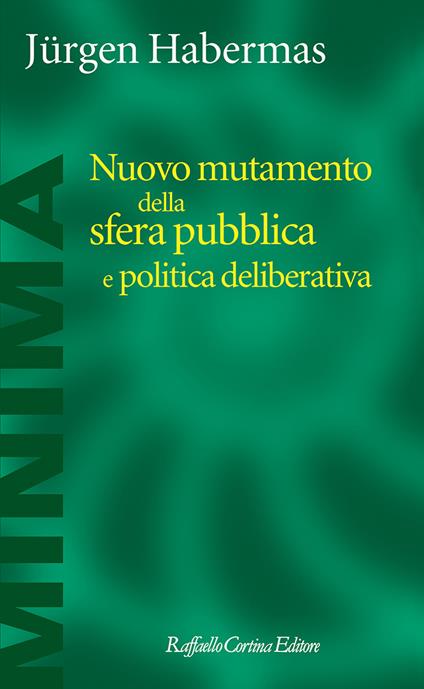Nuovo mutamento della sfera pubblica e politica deliberativa
di Jürgen Habermas
Raffaello Cortina editore
Cosa c’entra Habermas con Elon Musk? Certo, quest’ultimo è, tra i due, il più noto, come l’uomo più ricco del mondo, con una stravagante vita familiare, un istrione visionario e megalomane, che unisce immensa potenza economica, tecnologica (dalla comunicazione al militare) a quella politica.
Habermas, più “banalmente”, nato a Düsseldorf nel 1929, deve la sua grandezza al suo pensiero critico, sociologico e filosofico, fortemente innovativo delle teorie dell’agire comunicativo, dell’opinione e dell’etica pubblica, della sfera pubblica politica, della democrazia deliberativa.
La maggior parte dei membri, da Chad Hurley a Elon Musk fino a Reid Hoffman, fondatori della cosiddetta “Mafia di PayPal”, che in seguito sviluppano le aziende tecnologiche di Silicon Valley (Tesla, Inc., LinkedIn, Palantir Technologies, SpaceX, Affirm, Slide, Kiva, YouTube, Yelp, Yammer, Meta, X, TikTok,) ha studiato presso l'Università di Stanford o l'Università dell'Illinois, intrecciando la filosofia e la computer science. Alcuni sono laureati in filosofia e si ispirano alla scuola di Francoforte, Alex Karp si è laureato con Habermas, utilizzando la sua teoria della comunicazione libera da rapporti di potere, da ogni vincolo eteronomo dello Stato, di partiti e sindacati, di chiunque intrappoli in correttezza, verità, veridicità, comprensibilità…
Secondo loro, le nuove tecnologie, senza regolamentazioni, libere di far circolare falsità e manipolazioni, soddisfano il desiderio individuale di immaginare la propria realtà come vera. Il nuovo sogno americano è questo, che ogni vero americano sia libero di credere senza limiti, che la terra è piatta e che covid e vaccini sono opera di un complotto, che Trump ha vinto nel 2020, che l’America ha la missione da Dio...
È evidente che il richiamo ad Habermas e alla Scuola di Francoforte (che tra loro hanno posizioni diverse e invece vengono assembrate) è strumentale, ma è significativo come questo gruppo costituisca un sistema non solo finanziario- tecnologico-militare, ma anche ideologico e politico, mescolando anche visioni religiose-messianiche e futuribili. Una visione capace di creare il sogno di un “nuovo mondo” che ha bisogno di un governo che decide con gesti forti, immediati, simbolici, senza gli intoppi della democrazia.
Questa premessa introduce il saggio di Habermas che intende denunciare, come viene detto nell’introduzione da Marina Calloni, il mutamento strutturale “dovuto all’affermarsi dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, tale da avere un decisivo effetto sui processi deliberativi della democrazia e della stessa formazione della volontà e dell’opinione dei cittadini, soprattutto in merito a questioni di interesse comune”.
La rivoluzione digitale impone a Habermas una nuova riflessione in relazione ai pericoli che le democrazie liberali corrono nel nuovo spazio illimitato di Internet, dove si formano patologie sociali promosse da una distorta comunicazione. Il saggio analizza come il progresso tecnologico della comunicazione digitalizzata porta alla frammentazione della sfera pubblica in un insieme disperso e modifica radicalmente la coscienza politica dei cittadini.
Il problema, per Habermas, viene da lontano in quanto la sfera pubblica borghese, come spazio della libertà contro le intrusioni dello Stato e di altri poteri esterni, regredisce e indebolisce i potenziali emancipativi, quando si vincola sempre più “agli imperativi del mercato e alle logiche del capitalismo”. Viene meno la comunicazione libera dal dominio, indispensabile per la democrazia dove tutti i cittadini, legati da vincoli di solidarietà, siano effettivamente liberi e uguali, con le stesse opportunità e pari condizioni di esprimere le proprie ragioni e volontà.
L’esaurirsi del dibattito pubblico viene, quindi, già dalla regressione politica di quasi tutte le democrazie occidentali dalla fine del secolo scorso con la svolta neoliberista e la globalizzazione finanziaria. La digitalizzazione, come causa dell’indebolimento della formazione deliberativa dell’opinione pubblica, va analizzata nella complessità delle cause della crisi delle democrazie capitalistiche, con lo sviluppo di tendenze privatistiche, che rafforza le disuguaglianze sociali, porta a una depoliticizzazione crescente e alla destabilizzazione delle democrazie. “Ora i segni della regressione politica sono visibili a occhio nudo”. Lo Stato perde la sua stessa sostanza democratica. Inquietante è l’odierno fenomeno della combinazione tra il tradizionale populismo di destra - Noi siamo il popolo - e l’egocentrismo liberista dei teorici che difendono i diritti soggettivi di libertà contro l’oppressione dello Stato democratico.
Oggi il decadimento della sfera pubblica politica mostra i limiti della pretesa egualitaria-universalistica propria della sfera pubblica borghese per un’uguale inclusione di tutti i cittadini che sembrava finalmente soddisfatta dai nuovi media (giornali e TV). Questa regressione politica pone la questione di cosa accade alle democrazie in cui la sfera pubblica politica si disintegra e si allenta l’interazione tra i partiti politici e l’opinione pubblica.
Per Habermas condizione necessaria della democrazia è la comunicazione pubblica che costituisce il nesso necessario tra l’autonomia politica dell’individuo e la formazione della volontà politica comune di tutti i cittadini. È lo spazio della comunicazione pubblica intersoggettivamente esercitata che permette l’autonomia individuale, l’esercizio dei diritti soggettivi entro legami di solidarietà per il bene comune.
Si ha un capovolgimento rispetto all’idea liberale che afferma invece un primato originario delle libertà individuali sui legami sociali di solidarietà funzionale a dare a tutti i cittadini pari opportunità per condurre una vita autodeterminata. La finalità liberale dello Stato di diritto, che è garantire ai cittadini uguali libertà private come diritti soggettivi, si può realizzare solo se le stesse persone hanno il ruolo di co-legislatori democratici e si avvalgono degli stessi diritti di comunicazione e di partecipazione politica.
Il compito della politica “non deve esaurirsi nel nudo accomodamento interessi privatistici né in compromessi disinvolti”. Problema centrale è la comune formazione della volontà pubblica, attraverso le istituzioni dello Stato democratico, al fine di integrare i propri interessi individuali con l’interesse comune dei cittadini-istituzioni. Il punto di vista individualista considera, invece, la modalità di formazione delle opinioni e delle volontà comuni, delle decisioni, come una questione privata dell’individuo.
di Carlo Bolpin