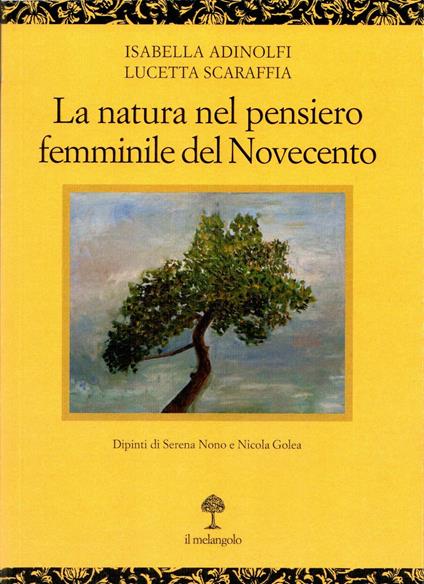La natura nel pensiero femminile del Novecento
di Isabella Adinolfi e Lucetta Scaraffia
Il Melangolo 2022
Si presenta ancora come uno stereotipo piuttosto scontato il fatto che la Natura, a partire dal suo genere grammaticale e dalla sua origine etimologica (nascor) sia appannaggio delle donne, mentre la cultura lo è degli uomini. Le donne danno la vita, gli uomini il senso. E così via fino a irrigidire in una gerarchia ciò che è più - maschile - o meno - femminile - importante.
Isabella Adinolfi e Lucetta Scaraffia nel libro La natura nel pensiero femminile del Novecento hanno per così dire preso sul serio questa attribuzione, cercando quanto e soprattutto come diverse pensatrici, scrittrici e filosofe del Novecento abbiano pensato la Natura, dandole voce, attraverso i loro scritti, che siano romanzi, lettere, poesie e altri testi.
Ne è uscito questo interessante volume collettaneo, che in esergo propone la poesia di Simone Weil Lampo, come folgorante meditazione sul tema che verrà affrontato. Il libro si presenta con una prefazione a quattro mani, suddiviso in dieci capitoli, ciascuno dedicato a una pensatrice, e redatto dalle studiose che ne hanno indagato l’opera: Antonella Salomoni, Loredana Bolzan, Bruna Bianchi, Ricciarda Ricorda, Anna Foa, Wanda Tommasi, Maria Concetta Sala, Laura Boella e le curatrici, Isabella Adinolfi e Lucetta Scaraffia.
In tal modo viene presentato un pensiero plurale sulla Natura, che ci pare particolarmente significativo di questi tempi, caratterizzati da due aspetti negativi dell’umano antropocentrico maschile - che si considera l’universale neutro - che sono: il climatico e le guerre. Di entrambi, in modi diversi ma molto stimolanti, il pensiero femminile si pone come pensiero totalmente altro.
In tutte le autrici analizzate emerge la grande capacità e il desiderio di osservare le piccole e grandi cose che le circondano: alberi, animali piccoli e grandi, fiori e piante, paesaggi, cieli, mari, tempeste, albe e tramonti. Emerge ancora la paziente ricerca per riuscire a esprimere queste osservazioni, e ciò che suscitano: vissuti e sentimenti, in una scrittura pienamente efficace.
Questo pensiero non nasce dal nulla, ovviamente, ma dal confronto con coloro, i maschi, che le hanno precedute o sono loro contemporanei. Ma le curatrici ci fanno notare come dallo studio di queste intellettuali emerga quello che loro chiamano Amor Fati, con delicatezza e decisione.
A differenza di Leopardi, ad esempio, nel quale l’uomo si ritiene ancora al centro dell’universo, malgrado la Natura non si curi affatto di lui, le pensatrici considerate ci offrono la possibilità non solo di collocarci dentro questa Natura, ma addirittura di amarla: una rosa appassirà, ma ci sarà sempre un’altra fioritura.
L’ordine con cui sono presentate le pensatrici è quello dell’anno di nascita, valorizzando così il trascorrere del tempo necessario per lo sviluppo potente e libero del pensiero femminile.
Si inizia con Zinaida Nikolaevna Gippius, (1869 -1945), considerata la fondatrice della poesia russa moderna. Per lei “i versi sono la mia preghiera. E il dono di scriverli - non importa se buoni o cattivi - non lo cambierei con nessun altro dono”. Ecco un esempio:
Guardo il mare con occhi avidi,
Incatenato a terra, sulla riva...
Mi tengo sull’abisso - sopra i cieli -
E non posso volare verso l’azzurro.
Non so se alzarmi o rassegnarmi,
non ho il coraggio di morire né di vivere...
Dio mi è vicino - ma non posso pregare,
voglio amore - e non posso amare.
Grande e attenta osservatrice della natura è Rosa Luxembourg (1871-1919), più conosciuta come rivoluzionaria che come sensibile artista. “Guarda quindi le cose da un angolo diverso e cerca il miele in ogni fiore: troverai sempre qualche motivo di sereno buonumore. [...] osservo le nuvole sempre più belle e senza sosta diverse, e in fondo io non mi considero più importante di quella piccola coccinella e, piena del senso della mia infima piccolezza, mi sento ineffabilmente felice”, così scrive in una sua lettera.
E quanto affascinante e ricco di suoni e colori è il mondo di Colette (1873-1954), fino dall’infanzia. È proprio la madre, Sido, a far scoprire alla piccola Colette la bellezza essenziale e la ricchezza rigenerante della Natura, che si può cogliere in ogni inizio, nell’alba come nello sbocciare dei germogli. Ed è la madre che viene meno all’incontro con l’amatissima figlia solo per attendere la fioritura del cactus che avviene ogni quattro anni. Ma è un’attesa voluta per attenuare il distacco che presagisce vicino. Originali, sempre creative e ri-creative sono le descrizioni degli animali, ma soprattutto dei fiori, di cui, se si vuole, si possono sentire i suoni, oltre che vedere le grandi trasformazioni.
Mary Webb (1881-1927), precursora dell’ecofemminismo, nata e vissuta nello Shropshire in Galles, in vita fu poco considerata per la sua arte, anzi quasi snobbata dagli ambienti intellettuali inglesi dell’epoca, e si dovranno aspettare molti anni perché le sue intuizioni, in particolare la connessione tra dominio della natura e oppressione delle donne vengano riconosciute.
Il pensiero di Simone Weil (1909-1943) sul rapporto tra uomo e Natura appare complesso e si sviluppa in varie fasi. In una prima fase, ben rappresentata dall’immagine della barca, l’uomo che la governa cerca un punto di equilibrio e non sovrasta la forza potente della Natura: homo naturae parendo imperat (l’uomo comanda alla natura obbedendole). Mutando la prospettiva successivamente, scrive Weil: “Nulla è bello come la gravità nelle fuggevoli pieghe delle onde del mare o nelle pieghe quasi sempiterne delle montagne”. Infine, quando il discorso diventa teologico, Weil descrive l’obbedienza, che è cieca per la Natura (il sole, la pioggia, il vento) e libera invece da costrizione per l’uomo, in quanto creatura conscia della sua creaturalità. “Nel momento in cui acconsentiamo all’obbedienza, siamo generati a partire dall’acqua e dalla spirito”.
In Elsa Morante (1912-1985) troviamo “la multiforme nazione” degli animali che abitano le storie da lei raccontate sia come protagonisti che come termine di paragone degli esseri umani. Ed è proprio con un passaggio di Aracoeli che Adinolfi e Scaraffia concludono la prefazione là dove si dice che la cacciata dall’Eden non rappresenta solo la perdita di qualcosa, ma la possibilità di cercare il frutto segreto in un altro nascondiglio, in altri regni. “Potrebbe essere una pietra, un’ala d’un insetto, una cenere d’ossa; o magari una parola inventata, un pensiero mai concepito da nessuno...” Si tratta di un invito a non stancarsi mai di cercare.
La Natura di Etty Hillesum (1914-1943) è quella che lei stessa vede nella sua vita quotidiana a Amsterdam prima e nella prigione di Westerbork dopo, ma è anche il sole che ha dentro di sé, che è ciò che le consente di sopportare il fango che c’è fuori e vivere nell’inferno del campo.
C’è un altro possibile modo di rapportarsi alla Natura che è quello che propone Anna Maria Ortese (1914-1998): condividere il respiro con tutti gli esseri viventi che non sono “cose”. Dedica perciò molta attenzione nel nominare il mondo perché le definizioni non spengano il mistero. Scrive: “Credo in tutto ciò che non vedo, e credo poco in quello che vedo. [...] Credo nelle piante che sognano e si raccomandano di conservare loro la pioggia. [...] Credo nel saluto degli uccelli, che sono anime felici, e si sentono all’alba sopra le case... In tutto credo, come i bambini”.
È particolarmente attenta al paesaggio Cristina Campo (1923-1977), prima di tutto quello della sua infanzia, vicino a Bologna, e poi degli altri luoghi della sua vita, come Firenze e Roma. Ed è sempre attenta al linguaggio, che sia dettagliato, preciso e semplice. Il ricco epistolario ce ne restituisce la voce poetica: “L’estate scorsa ho cominciato a scriverti quattro volte. C’erano mille cose che volevo dirti e domandarti. Abitavo una casa nel bosco, piena di farfalle, di scorpioni, di ragni, di mantidi religiose, di rospi e di bruchi - oltreché, s’intende, circondata di uccelli”.
Il rapporto con la Natura che ci propone la poesia di Silvia Plath (1932-1963) è ancora diverso. Attraverso l’analisi della poesia L’olmo vediamo come Plath evidenzia l’impossibilità da parte degli esseri umani di mettersi nei panni della Natura, ma contemporaneamente la necessità di ascoltare ciò che essa dice. Questa è la contraddizione nella quale siamo chiamati a vivere e che dobbiamo cercare di volta in volta di affrontare.
I dipinti di Serena Nono e Nicola Golea impreziosiscono il volume con immagini evocatrici di una Natura abitata da alberi, animali, umani in attesa di essere cercati.
di Gabriella Cecchetto, Anna Urbani
da Esodo n.2/2024, Dire la fede oggi, pp.70-73